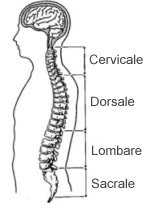Psicanalisi: - Scienza psicologica le cui basi essenziali sono state stabilite da Sigmund Freud. Con questo termine si intende sia il complesso di dottrine psicologiche generali, sia la tecnica di indagine dei processi psichici, sia il metodo psicoterapeutico. Sulla base di studi precedenti, dovuti soprattutto a Breuer, a Bern-heim, a Charcot e a Jenet, Freud giunse al completo rivoluzionamento del sistema di indagine psicologica, identificando il centro della vita psichica nell'inconscio, cioè in quella zona oscura della personalità individuale che si rivela alla coscienza unicamente attraverso il simbolo, soprattutto attraverso il sogno.
Psicanalisi: - Scienza psicologica le cui basi essenziali sono state stabilite da Sigmund Freud. Con questo termine si intende sia il complesso di dottrine psicologiche generali, sia la tecnica di indagine dei processi psichici, sia il metodo psicoterapeutico. Sulla base di studi precedenti, dovuti soprattutto a Breuer, a Bern-heim, a Charcot e a Jenet, Freud giunse al completo rivoluzionamento del sistema di indagine psicologica, identificando il centro della vita psichica nell'inconscio, cioè in quella zona oscura della personalità individuale che si rivela alla coscienza unicamente attraverso il simbolo, soprattutto attraverso il sogno.L'interpretazione dei sogni (1901), di Freud, costituisce infatti una delle opere fondamentali della nuova scienza, inaugurando l'indagine del sogno, e quindi dell'inconscio, sul piano scientifico. In contrasto con l'interpretazione statica dei fenomeni della vita psichica, propria della scienza tradizionale, Freud propone un'interpretazione dinamica ed energetica dei sintomi normali o patologici della psiche, in quanto considera i disturbi della personalità come derivanti non da una mancanza, da un venir meno di energie, ma da un conflitto di energie opposte, soprattutto dall'urto delle forze istintive dell'inconscio con la coscienza e con le sue istanze di controllo, determinate dalla morale sociale, che si traducono in un meccanismo di repressione.
La resistenza della coscienza determina, come effetto principale, la rimozione, l'allontanamento dei contenuti istintivi, che restano confinati nell'oscura profondità dell'inconscio, indicato da Freud con il nome di Es, cioè con il pronome neutro tedesco di terza persona, in contrapposto all'Ego, cioè all'Io cosciente, dominati rispettivamente dall'esigenza del piacere, dalla libido, e dall'esigenza di sicurezza.Nell'ambito dell'Es il gruppo di istinti dell'Eros rimasti inappagati si trasforma a sua volta in un gruppo di istinti di distruzione che possono compromettere gravemente l'equilibrio della personalità quando gli impulsi a vivere non offrono sufficienti resistenze agli impulsi a morire, contrapposti gli uni agli altri, secondo il mito poetico di Eros e Thanatos.
L'istanza repressiva dell'Io di fronte ai pericoli dell'Es assume a sua volta una propria autonomia, dando luogo al Super-Io, attraverso il quale l'immagine di un'autorità del mondo esterno, soprattutto i genitori, viene assorbita all'interno dell'Io e ne diviene parte integrante. La psicanalisi ha implicitamente dimostrato il fondamento reale delle sue affermazioni attraverso i successi conseguiti nel campo della terapia psicoanalitica, nella cura delle nevrosi, che costituiscono il suo scopo fondamentale, assumendo come strumento essenziale l'analisi del transfert, cioè della ripetizione nei rapporti affettivi adulti di modelli di comportamento infantile.
Dal primitivo orientamento freudiano si sono distaccate numerose correnti, fra cui fondamentali la psicologia analitica di Jung e la psicologia individuale di Adler, mentre si sono diffuse sempre di più le applicazioni della psicanalisi alle più varie forme di indagine scientifica, soprattutto alla pedagogia, alla sociologia, alla storia delle religioni, della letteratura e dell'arte in genere, all'etnologia, alla biografia, alla criminologia, eccetera.